Nell’ambito delle Antesterie aveva luogo ad Atene un’altra importante celebrazione, la “Festa dell’Altalena”, chiamata anche “Aiòra” (che significa appunto “dondolo” o “altalena”) o “Aletis” (“colei che vaga errando”).
In essa si commemorava la tragica e commovente figura mitologica di Erìgone. Costei era una fanciulla dell’Attica al cui genitore, Icario, Dioniso aveva fatto dono di un otre di vino e un tralcio di vite, insegnandogli la coltura della pianta vinifera, fino ad allora sconosciuta. Icario invitò un gruppo di pastori che pascolavano le greggi alle pendici del monte Pentèlico a gustare la nuova bevanda (1). Ma essi, inebriati dal liquore alcoolico, al quale non erano punto abituati, credettero l’ebbrezza un sintomo di avvelenamento e adirati uccisero Icario a bastonate; poi però si resero conto del misfatto che avevano compiuto, seppellirono il cadavere e se fuggirono lontano (2). Allora l’ombra di Icario apparve alla figlia Erìgone, che non aveva assistito al triste evento, poiché stava accudendo agli armenti in lontano pascolo, e la supplicò di cercare la sua sepoltura. Accompagnata dalla sua fida cagna, Màira, si mise alla ricerca del cadavere del padre; quando infine l’ebbe trovato, vinta dal dolore, si impiccò a un albero.
Attirati dai lamentosi guaiti della cagna, alcuni viandanti scoprirono il corpo esanime della fanciulla e le diedero sepoltura; la cagna Màira rimase accucciata presso la tomba di Erigone, dove alla fine morì anch’essa sopraffatta dal dolore per la perdita dell’amata padroncina. Secondo un’altra versione, la cagna Maira aveva visto i pastori mentre seppellivano il corpo di Icario sotto un pino e guidò poi Erigone al luogo della sepoltura, tirandola per un lembo della veste e scavando il terreno con le zampe. Disperata, la fanciulla si impiccò ai rami del pino, pregando affinché le figlie di Atene andassero incontro al medesimo destino fino a quando Icario non fosse stato vendicato. E così fu: Dioniso esaudì la sua dolorosa preghiera ed inviò agli Ateniesi un singolare castigo: ben presto molte fanciulle colte da una insana pazzia furono trovate che penzolavano impiccate ai rami degli alberi (3).
L’oracolo di Delfi, interrogato da un’ambasceria ateniese spiegò che il dio vendicava in tal modo la morte, rimasta impunita, di Icario e di Erigone. I pastori colpevoli del delitto furono ritrovati e condannati, e fu istituita una festa in loro onore, durante la quale si offrono libagioni e le fanciulle si dondolano sedute su piccole assi appese per mezzo di corde alle fronde degli alberi, in memoria della tragica fine di Erigone: così era stata inventata l’altalena; il triste ricordo che ne aveva suggerito l’uso col tempo si perse e più tardi divenne solo un lieto trastullo infantile (e non solo…).
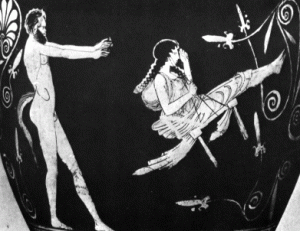 Come non di rado succede nella mitologia greca, Zeus, commosso dalla patetica vicenda, ne collocò i protagonisti nel firmamento: Icario divenne la costellazione di Boote (il Bovaro), Erigone quella della Vergine, mentre la cagna Màira fu mutata nella stella Sirio, – α Canis Maioris- della quale abbiamo parlato spesso nelle nostre trattazioni, chiamata “Canicula” dai Latini-(4): la “levata eliaca” (cioè poco prima del sorgere del Sole) in luglio di questa stella segnava l’inizio del periodo del caldo torrido, di “Opòra”, la prima parte della stagione dei frutti, mentre la levata eliaca di Arturo -α Bootis- la stella più splendente della costellazione di Boote, posta tra i piedi del “bovaro”, annunciava la seconda parte della stagione della raccolta dei frutti, quella più mite della vendemmia, nel periodo dell’anno nel quale Dioniso fu strappato dal grembo di Semele incenerita dallo splendore di Zeus -che ella incautamente, a causa delle maligne insinuazioni delle sorelle, aveva voluto si manifestasse a lei nel suo vero aspetto divino.
Come non di rado succede nella mitologia greca, Zeus, commosso dalla patetica vicenda, ne collocò i protagonisti nel firmamento: Icario divenne la costellazione di Boote (il Bovaro), Erigone quella della Vergine, mentre la cagna Màira fu mutata nella stella Sirio, – α Canis Maioris- della quale abbiamo parlato spesso nelle nostre trattazioni, chiamata “Canicula” dai Latini-(4): la “levata eliaca” (cioè poco prima del sorgere del Sole) in luglio di questa stella segnava l’inizio del periodo del caldo torrido, di “Opòra”, la prima parte della stagione dei frutti, mentre la levata eliaca di Arturo -α Bootis- la stella più splendente della costellazione di Boote, posta tra i piedi del “bovaro”, annunciava la seconda parte della stagione della raccolta dei frutti, quella più mite della vendemmia, nel periodo dell’anno nel quale Dioniso fu strappato dal grembo di Semele incenerita dallo splendore di Zeus -che ella incautamente, a causa delle maligne insinuazioni delle sorelle, aveva voluto si manifestasse a lei nel suo vero aspetto divino.
Pertanto il Cane, -o meglio la Cagna-, ci indica la strada per la vita e Dioniso trasforma la calura soffocante delle “giornate del Cane”, la canicola, nella pura luce della fine dell’estate allorché maturano le uve, dal cui “sacrificio” viene il nettare che ristora, -ma pure acceca!- gli spiriti, così come dal sacrificio di Dioniso viene la redenzione degli umani.
Nacque così anche così la festa dell'”Aòra” (o “Eòra”), poi compresa nel triduo delle feste Antesterie, precisamente nella notte tra il secondo (“Choes”) e il terzo giorno (“Chytroi”).
Durante questa strana cerimonia religiosa le fanciulle ateniesi oscillavano o si facevano dondolare da altri sulle altalene legate ai rami degli alberi, e cantavano la “Canzone dell’Errante” (Aletis), nella quale si narrava la patetica storia di Erigone: il dondolio delle altalene, che costituiva il rito centrale e caratterizzante della festa, voleva rimembrare in forma incruenta e in qualche modo “sdrammatizzata” il tragico destino delle fanciulle ateniesi che si erano impiccate per placare l’ombra di Erigone. Era uso anche appendere bambole e piccole maschere alle fronde di modo che fossero fatte oscillare dalle brezze.
Era uso anche appendere bambole e piccole maschere alle fronde di modo che fossero fatte oscillare dalle brezze.
In uno “skiphos” a figure rosse del V sec. a. C. sono rappresentati entrambi i momenti principali del mito e del rito che ne derivò: da un lato possiamo osservare una ninfa, Euanthea (la “Fiorente”) che viene sospinta su un’altalena da un satiro; dall’altro una donna procede spedita affiancata da un altro satiro che tine un parasole aperto sopra il suo capo e che quindi illustra l’angoscioso vagabondare di Erigone alla ricerca delle spoglie del padre -e per questo detta “Aλητις”, “errante, vagabonda” (< “αλαομαι”= errare, peregrinare)-. La festa dell’Altatlena si concludeva con un solenne banchetto offerto ai poveri.
Come abbiamo accennato in precedenza, l’antico uso di offrire ai defunti una sorta di zuppa costituita da un gran numero si semi e frutti secchi, – e per questo chiamata πανσπερμiα- si è continuato nelle tradizioni del cristianesimo orientale con la “κòλυβα” (che si pronuncia “kòliva”, poiché nel greco bizantino e moderno la beta ha assunto il suono V). Il termine era già in uso nell’età ellenistica, come neutro plurale, per indicare dolcetti o pasticcini di farina, sesamo e miele; -in origine però “κòλλυβος”, maschile singolare, significava monetina-. La “kòliva” è una specie di torta, di cui esistono molte varianti nelle aree dove vige la tradizione del cristianesimo orietale, -in particolare i Paesi balcanici e soprattutto la Grecia, nonché le popolazioni cristiane del Vicino Oriente-, confezionata principalmente con chicchi di frumento bolliti, dolcificati con miele, a cui si aggiungono diversi altri ingredienti ed aromi quali semi di sesamo, mandorle, nocciole, arachidi, pistacchi, chicchi di melagrana, uva passa, cannella, anice, ecc.; pertanto si può dire che la kòliva rimembra alcuni dolci delle tradizioni natalizie italiane.

Ad essa viene di solito conferita una forma rotonda, ma talora può essere anche ovale o rettangolare, ed è poi cosparsa con zucchero a velo. E’ comune usanza decorare la superficie della torta con le iniziali del defunto o dei defunti che si vogliono commemorare e con una, o più, candele che vengono accese all’inizio della funzione religiosa e spente al suo termine.
Negli ingredienti di questo dolce dal significato rituale si può rilevare la permanenza di un simbolismo proprio delle divinità dell’antica religione ellenica: il grano è per eccellenza il simbolo, e l’incarnazione di Demetra, la dea delle messi, la valenza sacrale come cibo, non solo per il corpo, ma pure per lo spirito, era al centro dei Misteri Eleusini; i chicchi di melagrana ricordano Core, la figlia di Demetra, che poi assunse il nome di Persèfone allorché dopo essere stata rapita da Ade, divenne regina degli Inferi: ella infatti dopo aver gustato sette (o sei) chicchi di melagrana dovette per forza rimanere nel regno delle ombre, -anche se fu poi stabilito che trascorresse sei mesi nell’oltretomba e sei mesi sulla terra- (5); la mandorla, sacra a Cibele, era simbolo di verginità (6); mentre, com’è ben noto, l’uva è il frutto (ma anche il “corpo” di Dioniso. Quanto ai semi di sesamo, essi furono considerati in grado di aprire le porte della conoscenza.
La “koliva” tuttora nei paesi di tradizione ortodossa, o che comunque seguono il rito bizantino, -e soprattutto in Grecia-, è consumata solo nelle ricorrenze legate ai defunti, sia durante la funzione e le preghiere che precedono le esequie dei singoli fedeli, -detta “panikhida” (dal greco antico παννυχiς = veglia funebre < παν -tutto- e νυξ -notte-); sia nella commemorazione di tutti i fedeli defunti, che, a differenza del cristianesimo occidentale, viene celebrata più volte durante l’anno liturgico (con differenze a seconda dei luoghi).
La principale e più solenne di queste commemorazioni, come è stato detto nella prima parte di questo articolo, è quella che si celebra il sabato antecedente la sessagesima, -la domenica che precede di due settimane l’inizio della quaresima-; ma un memoriale dei defunti è recitato, -sempre con la benedizione e il pio consumo della “kòliva”-, anche nel primo, secondo e terzo sabato di quaresima, e nel sabato prima di Pentecoste. In alcuni paesi, e in particolare in Russia, i riti funebri sono officiati pure nel martedì dopo Pasqua, e nel “sabato di S. Demetrio”, quello che cade più vicino alla festa di S. Demetrio Donskoj, gran principe di Mosca (il 26 ottobre), nella quale si ricorda la battaglia di Kulìkovo, combattuta l’8 settembre 1380 tra i Tartari dell’Orda d’Oro e una coalizione di principi russi e lituani guidata dal Donskoj, che ne uscirono vincitori.
Un dolce simile alla “kòliva” viene preparato in Libano in occasione della festa di S: Barbara il 4 dicembre, ed è denominato per tale ragione “barbara” o “varvara”, o anche “snuniye”.
Un’altra antica festa dell’antica Roma nel quale si ritrovano aspetti da un lato del “carnevale”, dall’altro del “capodanno”, sono i “Lupercali” (“Lupercalia”) che aveva luogo il 15° giorno avanti le calende di marzo (“ante diem XV Kalendas Martias”) ovvero il 15 febbraio -quindi in un periodo dell’anno che coincide con il nostro “carnevale”-. Quest’ultimo d’altro canto si può a sua volta considerare simile, se non coincidente, con il “capodanno”, poiché nell’uno e nell’altro si ha una “sospensione” dell’ordine cosmico e sociale propria dell’inizio di un nuovo ciclo, -oltre che un più o meno esplicitamente riconosciuto “ritorno dei morti”-, in cui si si vuole riprodurre una sorta di caos primigenio, dal quale sorga un migliore assetto nelle cose naturali e umane. Nei Lupercali sono presenti i tipici atteggiamenti carnevaleschi: il travestimento, la maschera, la parodia, lo scherzo, anche pesante e volgare, la temporanea abolizione delle distanze sociali, il riso, la beffa, tutti comportamenti “liberatori”, che avevano, -ed hanno tuttora-, la duplice funzione di eliminare ed esorcizzare sentimenti ed impulsi socialmente pericolosi, -almeno in potenza-, e di catalizzare energie fisiche, psichiche e mentali ed incanalarle poi ad uno scopo costruttivo. L’osservazione più interessante su questa festa è che, -come vedremo in seguito in modo più approfondito-, è che essa sopravvisse a lungo alla fine del cosiddetto “paganesimo” e alla proibizione ufficiale di tutti i culti non cristiani decretata nel 391 dall’imperatore Teodosio, nonché dell’Impero Romano d’Occidente, tanto che è attestata a Roma ancora nei primi secoli del Medio Evo. Questo significa che aveva perso il carattere propriamente religioso (considerando pure che i sacerdozi che dovevano ad essa presiedere non esistevano più) ed era diventata una sorta di carnevale, di momento ludico collettivo, di fiera paesana, seppure criticata e riprovata dalle gerarchie ecclesiastiche.

La festa era celebrata in onore di Lupercus, antico dio latino al quale, come dice il nome (che secondo un’etimologia non certa deriverebbe da “lupos arceo” = allontano i lupi) era demandato il compito di difendere le greggi e gli armenti dagli attacchi dei lupi; in seguito tale nome fu considerato epiteto di Fauno (Faunus Lupercus) e infine assimilato al greco Pan Liceo. Paredra del dio è Luperca, identificata poi con Acca Larenzia, la sposa di Fàustolo, il pastore che trovò e adottò Romolo e Remo. Il rito principale aveva luogo davanti al “Lupercale”, la grotta alle pendici del colle Palatino ove Fàustolo scoprì neonati gemelli allattati dalla lupa sotto le fronde di un fico detto “Ficus ruminalis”.
Gli officianti dei Lupercali erano i membri di una “sodalitas”, chiamati “Luperci”; tale collegio era suddiviso in due sodalizi di 12 membri ciascuno, i “Luperci Quinctiales” e i “Luperci Fabiani”; nel 44 a. C. fu aggiunta una terza schiera, i “luperci Iulii”, in onore di Giulio Cesare, ma essa fu soppressa dopo la morte del sommo duce. Codesto collegio sacerdotale, e il rito da essi celebrato, come diversi altri, era alquanto decaduto alla fine dell’età repubblicana, ma fu poi restaurato da Augusto, il quale peraltro lo riservò all’ordine degli “equites”, i Cavalieri, la seconda delle classi sociali-censitarie romane, mentre in precedenza era stato proprio dei patrizi. Il rituale proprio dei Lupercali constava di due fasi distinte: nella prima i due sodalizi dei Luperci si recavano alla grotta del Lupercale e quivi immolavano quali vittime sacrificali alcune capre (se ne ignora il numero esatto, ma dovevano essere almeno due) ed un cane, mentre le Vestali, che intervenivano anch’esse al rito, offrivano delle focacce confezionate con la farina ottenuta dalle prime spighe mietute nel raccolto dell’anno precedente. Secondo quanto riferisce Ovidio, -in “Fasti”, II, 282-, presiedeva a questa parte della cerimonia il “Flamen Dialis” (ossia il più importante membro del collegio dei Flàmini, sacerdote di Giove) (7).
Nella fase successiva del rito due giovani, ciascuno appartenente ad uno dei due sodalizi, venivano toccati sulla fronte con il coltello sacrificale intinto del sangue delle vittime immolate (8). Il segno di sangue sulla fronte veniva poi deterso con un batuffolo di lana immerso nel latte caprino; mentre questa operazione veniva compiuta, i due giovani dovevano ridere o sorridere, in modo più o meno spontaneo

. A parere di alcuni, sul fondamento di quanto riferisce Plutarco nella “Vita di Romolo”, i due giovani che subivano questo trattamento erano due nuovi adepti i quali venivano cooptati nella “sodalitas”, e dunque la cerimonia descritta sarebbe stata anche un rito di iniziazione. Indi essi venivano rivestiti delle pelli delle capre scarificate, o per meglio dire si facevano con esse una sorta di perizoma, mentre il resto del corpo rimaneva nudo, ma unto di olio; in viso si disegnavano col fango una sorta di maschera rituale. Dalle pelli caprine venivano pure ricavate delle strisce (chiamate “februa” o “amicula Iunonis”), che venivano usate come fruste. A questo punto del rito i Luperci si mettevano a correre intorno alle pendici del colle Palatino, -una delle due schiere in una direzione e l’altra nel senso opposto, fino a tornare al luogo di partenza- colpendo con forza con le sferze che brandivano, sia il suolo per propiziarne la fertilità, sia tutti coloro che incontrassero sul, loro cammino, in particolare le donne, le quali soprattutto nelle età più antiche si offrivano volontariamente a queste percosse che avrebbero dovuto renderle feconde.
Come si può arguire da questa sommaria descrizione i riti con i quali si celebravano i Lupercali erano assai arcaici e rimandavano ad un remoto passato, alla preistoria delle popolazioni indoeuropee e alla loro barbarica vitalità. Secondo lo storico greco Dionisio di Alicarnasso (“Archeologia Romana”, I,90) questa festa sarebbe stata istituita da Evandro che si era ispirato ad analoghe cerimonie dell’Arcadia, le regione del Peloponneso donde egli era giunto nel Lazio fondandovi la città di Pallanteo e che si alleò poi ad Enea. Ovidio narra (“Fasti”, II, 429-452) che durante il regno di Romolo, dopo che egli aveva orchestrato il ratto delle Sabine per incrementare la scarsa popolazione femminile della neonata Roma, si ebbe un prolungato periodo di sterilità nelle donne latine e sabine. Pertanto esse si recarono in devota processione al bosco sacro a Giunone alle pendici dell’Esquilino e qui si prostrarono in umile supplica alla dea. Con lo stormire delle fronde Giunone rispose che avrebbero dovuto essere copulate da un sacro caprone: questo inquietante responso provocò comprensibile sgomento nelle donne. Ma un augure etrusco diede l’esatta interpretazione dell’oracolo, affermando che si sarebbe dovuto sacrificare un capro e con la sua pelle ritagliare delle strisce: con esse sferzò la schiena delle donne ed esse concepirono.
Da questo episodio sarebbe derivato il rito centrale dei Lupercali. Il rituale della seconda parte della celebrazione dei Lupercali appare costituito di tre elementi distinti: il primo, -la circumambulazione del colle Palatino, ovvero del nucleo centrale e più sacro della città di Roma-, è di carattere purificatorio. Esso in origine doveva essere compiuto dai pastori intorno al gregge per difenderlo dall’assalto dei lupi chiudendolo entro un cerchio magico ed in esso viene evocata una forza magica e impersonale, -un “numen” più che un vero e proprio dio, come erano molte delle divinità venerate nelle fasi più arcaiche della civiltà romana-; questo spiega l’incertezza della tradizione circa il patrono della festa, o meglio, circa la figura divina nella quale la forza magica evocata era impersonata: Fauno Luperco (Ovido, Fasti, II, 361); Inuo (una divinità assimilabile alla precedente) (Livio, “Ab urbe condita”, I, 15); Libero -ovvero la versione latina di Dioniso (Servio, “Ad Aeneidem”, VIII, 343): si tratta comunque sempre di divinità legate al mondo delle selve e dei pastori.
Il secondo elemento è iniziatico e proprio della confraternita (poiché in effetti le “sodalitates” romane si possono assimilare alle confraternite odierne dedicate al culto locale di qualche santo) dei Luperci, nella quale i nuovi adepti venivano identificati nella vittima sacrificale sia nella morte, -ricevendone il sangue sulla fronte-, sia nella resurrezione con il latte, alimento tipico dell’infanzia e quindi indicativo della nascita, e con il riso, dal valore liberatorio e confermatorio.
Il terzo elemento è propiziatorio: i Luperci divenuti “uomini-capri” (come Pan, a sua volta assimilato a Fauno), e rivestita la pelle dell’animale, di cui incorporavano così le virtù, procuravano alla terra e alle donne la fecondità. Ma nello stesso tempo erano pure “uomini-lupi” (come dice il loro stesso nome), che si appropriavano della ferinità del lupo per incanalarla a un fine positivo e protettivo.
Come si è detto, questa festa resistette a lungo anche dopo l’affermarsi del cristianesimo e si può annoverare tra le antiche tradizioni che, trasformandosi, andarono a costituire il “Carnevale” europeo. Si ha ricordo di una celebrazione dei Lupercali in Roma al tempo di Antemio, imperatore d’occidente dal 467 al 472; e poi, dopo che fu temporaneamente negletta, nel 494, -quando l’Impero Romano d’Occidente era definitivamente tramontato-, allorché il senatore Andròmaco ne dispose la celebrazione per placare una pestilenza che stava desolando la città. In quella circostanza papa Gelasio I criticò aspramente il senatore proibendo ai fedeli di partecipare alla cerimonia. Si ha ragione di credere però che la festa, anche se in forme ridotte e semiclandestine, sia sopravvissuta ancora a lungo (9). 
Talora si è supposto che alla festa dei Lupercali sia stata sostituita quella della Purificazione di Maria Vergine (popolarmente detta “Candelora”) -secondo quanto leggesi nel vangelo di Luca (II, 22-29)-, da papa Gelasio I o dai suoi immediati successori, ma l’ipotesi è poco sostenibile: sia perché la festa cristiana viene celebrata il 2 febbraio (e non il 15), sia perché non se ne ha menzione in Roma prima della fine del VII secolo. Tuttavia si sa, -dalla testimonianza della monaca Eteria (o Egeria) (10)- che la festa della Purificazione della BVM era celebrata a Gerusalemme 40 giorni dopo la Natività (secondo la narrazione evangelica) almeno dalla metà del IV secolo, e poiché in Egitto, Siria e Palestina la Natività di GC ricorreva il 6 gennaio (11), la data di tale celebrazione liturgica cadeva proprio il 15 febbraio.
Peraltro si tenga presente che nei primi secoli non vi è alcun indizio che fosse solennizzata la nascita di Gesù Cristo; presso le comunità orientali si celebrava almeno fin dagli inizi del III secolo l'”Epifania”, ovvero la “manifestazione” della divinità, nella quale si comprendevano tre eventi distinti. l’adorazione dei Magi; il battesimo nel Giordano; e il primo miracolo compiuto alle nozze di Cana. In seguito nell'”Epifania” si comprese anche la nascita di Cristo, ma l’evento principale celebrato dagli orientali era (ed è nelle chiese monofisite) il battesimo (anzi, per i seguaci di alcune correnti ereticali, detti “adozianisti”, Gesù sarebbe divenuto il “figlio di Dio”, e quindi il “Cristo”, solo in quel momento, allorchè lo Spirito Santo scese su di lui in forma di colomba e in tal modo fu “adottato” da Dio -Matt, III, 16-17; Marco, I, 9-11; Luca, III, 21-22; Giov: I, 32-34- ).
il battesimo nel Giordano; e il primo miracolo compiuto alle nozze di Cana. In seguito nell'”Epifania” si comprese anche la nascita di Cristo, ma l’evento principale celebrato dagli orientali era (ed è nelle chiese monofisite) il battesimo (anzi, per i seguaci di alcune correnti ereticali, detti “adozianisti”, Gesù sarebbe divenuto il “figlio di Dio”, e quindi il “Cristo”, solo in quel momento, allorchè lo Spirito Santo scese su di lui in forma di colomba e in tal modo fu “adottato” da Dio -Matt, III, 16-17; Marco, I, 9-11; Luca, III, 21-22; Giov: I, 32-34- ).
Sappiamo tuttavia da alcuni autori antichi, in particolare da Clemente di Alessandria (in “Stròmata”, I, 21, 146), che già dalla fine del II secolo circolavano delle ipotesi o delle teorie sulla nascita di Gesù Cristo: alcuni affermavano che essa fosse avvenuta il 25 di “Pakhon”, il primo mese della stagione di Shemu, nel calendario egiziano alessandrino (corrispondente al 20 maggio); altri erano convinti che il lieto evento si fosse verificato il 24 o il 25 di “Pharmouti” , -il quarto mese di Pèret- (il 19 o 20 aprile). I seguaci dello gnostico Basilide ritenevano che Gesù fosse nato l’11 del mese di “Tybi”, -primo mese di Pèret-, (il 6 gennaio) e celebravano l’Epifania il 15 dello stesso mese (il 10 novembre) (12), mentre Epifanio di Salamina (città di Cipro) nel IV secolo dichiara che Cristo era nato il 6 gennaio ed era stato battezzato l’8 novembre (data che stranamente viene a coincidere con il “Mundus Patet” romano, come abbiamo detto nella prima parte della presente ricerca). Ugualmente per il 6 gennaio propendono Efrem il Siro (306-373), Cosma Indicopleuste (esploratore e pensatore eteredosso di origine siriaca vissuto nel VI secolo) (13) e Abramo di Efeso (VI secolo).
Nelle chiese occidentali osserviamo che Cipriano, vescovo di Cartagine (210-258) afferma nel “De paschae computus”, che Cristo sarebbe nato il 28 marzo, perché in quel giorno, secondo lui, fu creato il Sole (14). Da parte sua Ippolito di Roma (170-235), -considerato il primo antipapa, in contrapposizione a Callisto I, ritenuto dalla chiesa cattolica papa legittimo- proponeva per l’evento (commento a Daniele, IV, 23) la data del 23 aprile.
Quando tuttavia nella chiesa romana si decise di solennizzare la Natività di Cristo scegliendo la data del 25 dicembre, per farla coincidere con il “dies natalis Divi Solis Invicti”, -già ufficializzata dall’imperatore Aureliano nel 273-, ed assorbire così il simbolismo della religione solare in quella cristiana (che già tendevano ad identificarsi nella politica religiosa di Costantino nell’ ovvia equivalenza “Christos” = “Helios”, la festa della Purificazione di Maria veniva ad essere anticipata al 2 febbraio.

Ma pure questa data veniva a sovrapporsi con un’altra importante celebrazione del calendario romano, vale a dire il “dies natalis” di Iuno Sospita (o Iuno Sospes), -Giunone Salvatrice-. Il culto di questa ipostasi della maggiore divinità femminile italica e latina era peculiare della cittadina laziale di Lanuvium; quando essa entrò nel dominio di Roma nel 338 a. C. il culto di Iuno Sospita fu accolto fra quelli ufficiali dello stato romano e celebrato in particolare alle Kalende di febbraio nel tempio della dea sul colle Palatino. Anche in questo culto l’aspetto precipuo era quello della purificazione, e per questo Iuno Sospita era detta anche Februa o Februalis; inoltre era usuale in questa circostanza accendere nei templi e nelle case torce, lucerne e candele.
Non solo, ma il 2 febbraio coincideva pure con un’altra festività “pagana”, sebbene celtica e non romana, ovvero Imbolc. Tale celebrazione – una delle quattro principali del calendario celtico-, solennizzava il culmine dell’inverno e nello stesso tempo il preannuncio della primavera, ed era caratterizzata dall’accensione di torce e fuochi, tradizione poi passata alla “Candelora” cristiana, che prese il nome appunto dai ceri e dalle candele portate in processione a Roma attraverso il Foro fino alla basilica di S. Maria Maggiore (“dies festus candelorum”). Tuttavia come abbiamo detta questa festa, che esisteva in Oriente già dal IV secolo, non è attestata a Roma prima del VII. Osserviamo tuttavia che tutte queste ricorrenze religiose (Lupercali romani, Imbolc celtico, Candelora cristiana) hanno in comune il carattere lustratorio e purificatorio, e si celebravano in febbraio: questo mese già nel suo nome, -che deriva dal verbo latino “februare” = purificare, e in particolare mondare da quanto è impuro, guasto o corrotto-, esprime questa valenza che gli era propria e rimanda al dio Februus, misteriosa divinità sotterranea, della quale poco si conosce, di probabile origine etrusca -come afferma Macrobio (“Saturnali”, I, 4, 3)- ed assimilata poi dai Romani a Dispater, altro antico dio latino legato agli Inferi, considerato figlio di Saturno e di Opi, ed indentificato poi con l’Ade greco (15).
Note
1) secondo un altro mito, il primo dei viticultori sarebbe stato Enopione, figlio di Dioniso e Arianna, al quale il padre aveva insegnato la coltura della vite e il procedimento per produrre il vino. Questo personaggio si inserisce nella storia di Orione, il quale, invaghitosi di sua figlia Merope, gliela chiese in sposa. Enopione acconsentì alla condizione che Orione, famoso cacciatore, lo liberasse dalle belve che infestavano le sue terre. Questi eseguì l’impresa che gli era stata richiesta, ma Enopione non ne riconobbe l’efficacia e si rifiutò così di dargli sua figlia in sposa. Orione, adirato che non avesse tenuto fede al patto, e in preda ai fumi dei vino di cui aveva bevuto un intero otre usò violenza a Merope. Dioniso, pregato da suo figlio, incaricò alcuni satiri di rendere ancora più ebbro Orione, così che caduto in un profondo torpore, fu accecato da Enopione.
2) sull’ambivalenza del vino, al tempo stesso sangue di una divinità e veicolo di salvezza, tramite il quale ci si immedesima in una divinità, e causa di ottenebramento della mente e di regressione negli abissi dell’incoscienza, ora non ci soffermiamo. Ricordiamo solo che il ricorso a una “bevanda sacra”, più o meno inebriante, si riscontra in moltissimi culti e tradizioni religiose -basti pensare al “soma” degli Indù vedici, all'”haoma” (che corrisponde o si identifica nel precedente) dei Persiani, al “ciceone” la bevanda offerta a coloro che si accostavano ai Misteri di Eleusi, sacri a Demetra e Persefone-. Anche per i seguaci di Dioniso il vino era il sangue del dio versato per la salvezza del mondo quando fu trucidato dai Titani; e Dioniso stesso è rappresentato a volta come un grappolo, destinato ad essere spremuto per divenire vino, tramite il quale portare al mondo la redenzione: la stessa cosa avverrà nel cristianesimo dove il vino è il “sangue di Cristo versato per la salvezza del mondo”.
3) Dioniso era anche il dio che inviava la pazzia, l’ottenebramento e l’accecamento della mente che induce a compiere gli atti più insani.
4) oltre che Erigone, nella costellazione della Vergine i Greci vedevano anche Dike, o Astrea, dea della giustizia, -emigrata in Cielo quando vide che sulla terra non v’era posto per lei-; ovvero Demetra in cerca di Core rapita da Plutone. Gli Egizi la interpretavano come Iside mentre allatta il piccolo Horus, mentre i Babilonesi erano certi che fosse Ishtar. Per altri Maira fu mutata nella stella Arturo -α Bootis- (nome che significa “coda dell’orso” o “guardiano dell’orso”, e allude alla sua vicinanza all’Orsa Maggiore), -il che peraltro sarebbe più logico quanto alla topografia celeste, essendo questa stella assai più vicina di Sirio a Boote (Icario) e alla Vergine (Erigone). Boote era Horus per gli Egizi.
5) la melagrana aveva infatti un valore ambivalente: da un lato era simbolo di rigoglio e fecondità; dall’altro era il cibo dei morti: Ma, come abbiano detto più volte, tra il culto dei morti e la fertilità esisteva in antico uno stretto e intimo legame che permane talvolta seppure obliterato nel suo profondo significato, in alcune usanze ormai relegate nel declinante patrimonio folcloristico (come quelle che abbiamo segnalato in questa trattazione).
6) secondo il mito anatolico, il mandorlo era nato dal sangue del mostruoso essere ermafrodito Agdistis, che aveva imbevuto e fecondato la Terra allorché egli fu evirato da Dioniso. I frutti di quell’albero, gustati da Nana, figlia del re Sangario, ingravidarono la principessa ed ella partorì Attis, il dio frigio la cui figura è simile a quella di Adone, di Dioniso, del nordico Balder, ecc. Anche nel cristianesimo la mandorla fu associata alla Vergine Maria.
7) i “Flàmines” erano il più elevato collegio sacerdotale dell’antica Roma, dopo quello dei “Pontifices”, costituito da 15 membri, dei quali i tre di più alto grado erano il Flàmen Dialis, il F. Martialis e il F: Quirinalis, consacrati rispettivamente a Giove, Marte e Quirino.
8) il verbo “immolare” significava cospargere il capo della vittima con la “mola salsa” una miscela di farina di farro e sale, operazione che era indispensabile eseguire prima di qualsiasi sacrificio.
9) in effetti soprattutto nelle campagne, -dove in Italia nel IV secolo il cristianesimo, quando fu imposto come religione ufficiale, era ancora scarsamente o per nulla professato-, nei primi secoli del ME si verificò una sorta di osmosi tra le credenze e i riti cristiani, e le pratiche delle antiche tradizioni religiose, che erano quelle autenticamente sentite dal popolo. Non a caso “religio pagana” significava appunto “religione di campagna” (da “pagus”, cioè il distretto di campagna che si estendeva su ville ed abitazioni isolate). Un esempio illuminate è quello delle processioni: esse in origine erano considerate dai cristiani un uso riprovevole, -in quanto proprio delle religioni gentili (ed in effetti la “processione” è una pratica religiosa che riscontra in pressoché tutte popolazioni antiche e moderne di un certo grado di civiltà dall’antico Egitto all’India, dagli Assiro-Babilonesi ai Germani, alle genti dell’America precolombiana); ma poi a partire dalla metà del IV secolo divennero parte integrante della liturgia cristiana, che sostituì in esse la celebrazione degli dei “pagani” quella di Cristo, della Vergine Maria e dei santi cristiani.
10) monaca, di presumibile origine iberica, che nella seconda metà del IV secolo effettuò un pellegrinaggio nei luoghi santi della religione cristiana e ne lasciò un diario noto come “Peregrinatio Aetheriae”, ovvero come “Itinerarium Egeriae” -poiché il nome della pellegrina è riportato ora come “Aetheria” ora come “Egeria” (è difficile dire se il secondo di questi nomi abbia a che fare con l’omonima ninfa che fu l’ispiratrice di Numa Pompilio, secondo re di Roma, nella sua opera di legislatore e civilizzatore)-.in cui descrive il luoghi da lei visitati.
11) com’è noto, tuttora la maggior parte delle chiese orientali celebra il Natale il 6 o 7 gennaio. Tuttavia si deve tenere presente che mentre alcune, -quelle monofisite, come la Chiesa Armena e la Chiesa Copta- si attengono alla data antica del 6 gennaio, per altre -quelle “ortodosse” in senso stretto-, che avevano accettato il 25 dicembre per solennizzare la natività, tale data è dovuta al fatto che essendo rimaste in genere fedeli al calendario giuliano (e non avendo quindi accettato le correzioni di quest’ultimo apportate dalla riforma di Gregorio XIII, avvenuta nel 1582), si è avuto un progressivo sfasamento dell’anno civile -e liturgico- rispetto all’anno astronomico.
12) il calendario egizio antico, costituito da 360 giorni distribuiti in 12 mesi, più 5 gironi “epagòmeni”, comprendeva soltanto tre stagioni: AKHET -stagione dell’inondazione (ovviamene del Nilo che fecondava con il fertile limo le terre circostanti), dal 19 luglio (data della “levata eliaca di Sirio”) al 15 novembre-; PERET -stagione dell’ermersione (ovvero del ritiro delle acque del Nilo), dal 16 novembre al 15 marzo-; SHEMU -stagione del calore o del raccolto-, dal 16 marzo al 13 luglio. I cinque giorni dal 14 luglio al 18 luglio erano detti “epagomeni” (=aggiunti) ed erano consacrati alle 5 principali divinità del ciclo osiriaco, -Osiride, Horus, Seth, iside, Nephtys-, di cui si celebrava rispettivamente la nascita. Poi nella Bassa Epoca (dal IX sec. a. C. in poi) ciascuna stagione fu suddivisa in quattro mesi con un nome proprio, che fu modificato secondo la fonetica greca nell’età tolemaica. Poiché l’anno egizio antico, essendo più corto di circa 6 ore dell’anno astronomico (e per questo detto “vago”), tendeva a slittare, e a non corrispondere più con le stagioni, Augusto nel 22 a.C. lo adeguò alla riforma operata da Giulio Cesare (il calendario giuliano), così che quell’anno fu aggiunto un sesto “giorno epagomeno”, e da allora l’anno ebbe inizio il 29 agosto: tale calendario, detto “alessandrino” e poi “copto”, è tuttora in uso presso i cristiani copti d’Egitto.
13) “Indicopleuste” significa “navigatore nei mari dell’India”; è noto soprattutto per l’opera “Topografia cristiana”.
14) come si possa stabilire una data del calendario, ovvero un punto preciso dell’anno, che corrisponde ad una rivoluzione solare della Terra o a un giro del Sole (se si rimane alla concezione geocentrica)- e non a caso “annus” significa propriamente “anello”- prima della nascita, o della “creazione”, che dir si voglia, dell’astro dal quale dipende il corso stesso dell’anno appare inspiegabile. D’altro canto è da rilevare che diverse teorie ritenevano l’Universo apparso o creato in coincidenza dell’equinozio di primavera, considerato punto di inizio dell’anno in diverse tradizioni cronografiche( ovviamente incorrendo nella medesima contraddizione sopra riportata).
15) in Roma antica era venerata pure una dea Febris, invocata in particolare contro le febbri malariche, che d’altra parte impersonava, a cui erano dedicati altari sul Palatino, sull’Esquilino e nel “Vicus Longus”, presso il Quirinale; sembra però che non avesse un diretto legame con Februus. Peraltro anche la febbre si può considerare una forma di “purificazione” poiché l’aumento della temperatura corporea è un mezzo con cui l’organismo cerca di liberarsi dalle tossine e dagli agenti patogeni.
